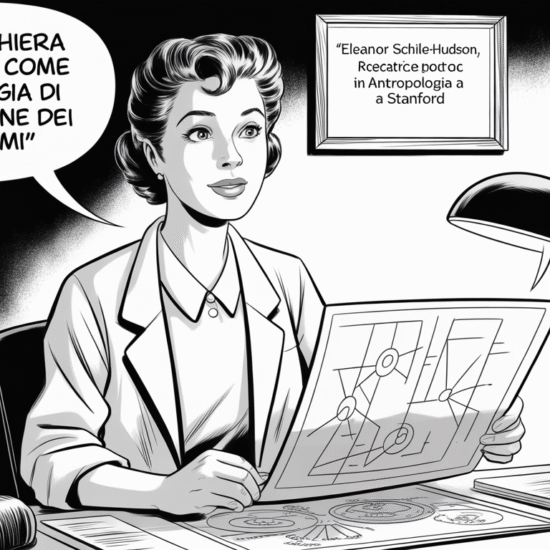Ovvero: come un monaco svedese e uno psicologo americano hanno scoperto la stessa verità scomoda
C’è un momento preciso in cui capisci di aver vissuto tutta la vita al contrario. Per Björn Natthiko Lindeblad, autore de “Il monaco che non voleva avere ragione”, è arrivato dopo 17 anni nella foresta thailandese, quando ha realizzato che il mantra più rivoluzionario al mondo sono tre semplici parole: “Potrei avere torto”.
Per Marshall Rosenberg, che in “Preferisci avere ragione o essere felice?” ha rivoluzionato il concetto di comunicazione nonviolenta, è scattato osservando come le categorie di giusto e sbagliato trasformassero ogni conversazione in un campo di battaglia. Due uomini, due percorsi, una scoperta devastante: siamo drogati di ragione.
La droga più pura del pianeta
Avere ragione è meglio del sesso, della cocaina e del cioccolato fondente messi insieme. È l’unica droga legale che crea dipendenza istantanea e ti fa sentire superiore agli altri. Il problema? Come tutte le droghe, alla fine ti distrugge.
Lindeblad lo sapeva bene. Ex manager svedese, aveva passato anni a vincere discussioni aziendali, a dimostrare la superiorità delle sue strategie, a essere quello che aveva sempre ragione.
Poi ha mollato tutto per diventare monaco buddhista nella foresta thailandese. Diciassette anni dopo, malato terminale, scrive un libro che diventa un caso editoriale mondiale. Il messaggio? “Potrei avere torto” non è una resa bianca, è una dichiarazione di indipendenza.
Dall’altra parte dell’oceano, Marshall Rosenberg arriva alla stessa conclusione ma da psicologo. Studia la comunicazione umana e scopre che dire “hai torto” è un atto di violenza psicologica. Non stiamo scambiando informazioni, stiamo dichiarando guerra. Ogni volta che etichettiamo qualcuno come “nel torto”, creiamo automaticamente un nemico che deve difendersi.
Il paradosso del combattimento
Ecco la cosa più assurda: più combattiamo per avere ragione, più spesso abbiamo torto. Non sui fatti, ma su quello che conta davvero. Perché quando trasformi ogni conversazione in una battaglia, hai già perso la cosa più preziosa: la possibilità di imparare qualcosa.
Lindeblad racconta di aver passato la prima parte della vita a collezionare vittorie intellettuali come trofei. Poi, nella foresta, ha capito che erano tutte medaglie di cartone. “Nulla dura, tutto passa”, scrive nel suo libro. “Ecco la cattiva notizia. Ma anche quella buona.”
Le tue opinioni di oggi saranno le superstizioni di domani. Quelle di ieri erano già obsolete prima di nascere. Perché sprecare energia a difendere qualcosa di così effimero?
Rosenberg va oltre: non solo le nostre posizioni sono temporanee, ma il modo stesso in cui le difendiamo è tossico. Quando dici “hai torto”, non stai comunicando un’informazione, stai creando un tribunale in cui tu sei giudice, giuria e boia.
L’altro non può che diventare imputato. E gli imputati, per sopravvivere, mentono, si nascondono o contrattaccano.
L’esperimento della foresta
Immagina di essere Lindeblad. Hai quarant’anni, una carriera di successo, e decidi di andare a vivere nella foresta thailandese come monaco. Niente telefono, niente internet, niente dibattiti su Facebook. Solo tu, la natura e la tua mente che continua a produrre opinioni su tutto.
Ma su cosa puoi avere opinioni nella foresta? Se pioverà domani? Se quella foglia è più verde dell’altra?
Dopo qualche anno ti rendi conto che il 90% dei tuoi pensieri erano solo rumore di fondo, chiacchiere mentali per riempire il vuoto. E che l’altro 10% erano comunque solo ipotesi provvisorie.
È lì che nasce il “potrei avere torto”. Non come filosofia, ma come esperienza diretta. Quando vivi senza dover dimostrare niente a nessuno, improvvisamente scopri quanto energia sprecavi nel cercare di avere ragione. È come togliersi uno zaino che non sapevi di portare.
La rivoluzione del dubbio
Rosenberg scopre la stessa cosa ma dall’interno delle relazioni umane. Osserva famiglie, coppie, organizzazioni e vede sempre lo stesso pattern: ogni conflitto nasce dal bisogno di stabilire chi ha ragione e chi ha torto. Ma questo bisogno è un’illusione. Dietro ogni posizione c’è un bisogno umano legittimo. Il problema è che quando ci attacchiamo alle posizioni, perdiamo di vista i bisogni.
“Preferisci avere ragione o essere felice?” diventa la domanda che cambia tutto. Perché la maggior parte delle volte non puoi avere entrambi. Ogni volta che scegli di avere ragione, stai scegliendo l’ego sulla connessione, la superiorità sulla comprensione, la solitudine sulla relazione.
La cosa più ironica? Quando smetti di aver bisogno di avere ragione, spesso ti ritrovi ad avere ragione più spesso. Ma a quel punto non ti importa più. Hai scoperto qualcosa di molto più interessante: la possibilità di cambiare idea.
L’epoca dell’incertezza
Viviamo nell’era più polarizzata della storia umana. Ogni argomento – dal clima ai vaccini, dalla politica alla cucina – diventa una trincea. I social media hanno trasformato ogni opinione in una bandiera da sventolare e ogni disaccordo in una guerra santa. In questo contesto, dire “potrei avere torto” è un atto rivoluzionario.
Lindeblad e Rosenberg ci stanno dicendo la stessa cosa: la certezza è sopravvalutata, l’incertezza è sottovalutata. Non perché la verità non esista, ma perché il nostro accesso alla verità è sempre parziale, temporaneo, influenzato dalle nostre esperienze e limitazioni.
Il monaco che rinuncia ad avere ragione e lo psicologo che smonta la violenza del giudizio stanno combattendo la stessa battaglia. Non contro la ragione, ma contro la tirannia della ragione. Non contro la verità, ma contro l’illusione di possederla.
La pratica della saggezza
Come si fa, concretamente, a vivere il “potrei avere torto”? Lindeblad suggerisce di iniziare dalle piccole cose. Quella discussione sul ristorante dove andare, quell’opinione sul film che avete appena visto, quel giudizio sul comportamento del vicino. Prova a dire “potrei avere torto” e osserva cosa succede. Prima dentro di te, poi nella conversazione.
Rosenberg va più a fondo: non si tratta di trovare modi più eleganti per vincere le discussioni. Si tratta di smettere completamente di pensare in termini di vittoria e sconfitta. Quando qualcuno dice qualcosa che ti fa scattare, invece di chiederti “ha ragione o torto?”, prova a chiederti “di cosa ha bisogno questa persona?”. È una rivoluzione neurologica, non linguistica.
La cosa più difficile non è ammettere di avere torto quando è evidente. È rinunciare al bisogno di avere ragione quando potresti averla. È scegliere la curiosità sulla certezza, la connessione sulla vittoria, la pace sulla superiorità.
Quando “papà ha sempre ragione” diventa una prigione
Conosco bene questa dinamica. Sono cresciuto con un padre il cui motto era “il papà ha sempre ragione!”. Una frase detta con la serietà di chi ci crede davvero, senza un briciolo di ironia. L’ironia non era nel suo repertorio – il sarcasmo sì, eccome. E vi assicuro che crescere in una casa dove qualcuno ha sempre ragione per decreto divino è un’esperienza formativa nel senso più completo del termine.
Quella frase non era uno scherzo, era una costituzione familiare non scritta. Creava una gerarchia epistemologica di ferro: c’è chi detiene la verità per diritto di nascita e chi deve sottostare. C’è chi può permettersi di contraddire tutti e chi non può contraddire nessuno. C’è chi giudica e chi viene giudicato, senza appello.
Il risultato? Ho passato anni a costruire la mia identità sull’essere quello che aveva sempre ragione. Perché se non puoi batterli, ti unisci a loro. Se la ragione è potere assoluto, meglio averla che subirla. Ho trasformato ogni conversazione in una gara intellettuale, ogni disaccordo in una battaglia da vincere a tutti i costi. Avevo sviluppato gli stessi meccanismi, solo con una patina di sofisticazione intellettuale che rendeva i colpi ancora più affilati. Il problema è che non ne ero minimamente consapevole – pensavo di essere semplicemente una persona intelligente che sapeva argomentare bene.
Ci sono voluti 45 anni di buddismo, lavoro su di me e – tra le altre cose – anche Lindeblad e Rosenberg per farmi capire che stavo perpetuando lo stesso schema, solo con strumenti più raffinati. Capire, però, non significa liberarsene. Non ancora.
Il coraggio di non sapere
Lindeblad muore nel 2022, dopo aver scritto un libro che ha venduto milioni di copie in tutto il mondo. Rosenberg è morto nel 2015, dopo aver rivoluzionato il modo in cui pensiamo alla comunicazione. Entrambi ci lasciano lo stesso regalo: il permesso di non dover sempre avere ragione.
Non è un invito al relativismo o all’indifferenza. È un invito al coraggio. Perché ci vuole molto più coraggio a dire “non lo so” che “lo so per certo”. Ci vuole più forza per restare aperti che per chiudersi nelle proprie certezze. Ci vuole più intelligenza per dubitare che per dogmatizzare.
Il monaco che non voleva avere ragione e lo psicologo che ha smontato la violenza del giudizio ci stanno dicendo che la saggezza non sta nell’accumulo di certezze, ma nella qualità del dubbio. Non nell’essere infallibili, ma nell’essere umani.
E forse, in un mondo che sembra aver dimenticato l'arte del dialogo, questa è la rivoluzione di cui abbiamo più bisogno. Non più argomenti, ma conversazioni. Non più vittorie, ma comprensione. Non più ragione, ma saggezza.Potremmo avere torto. E sarebbe la notizia migliore della giornata.